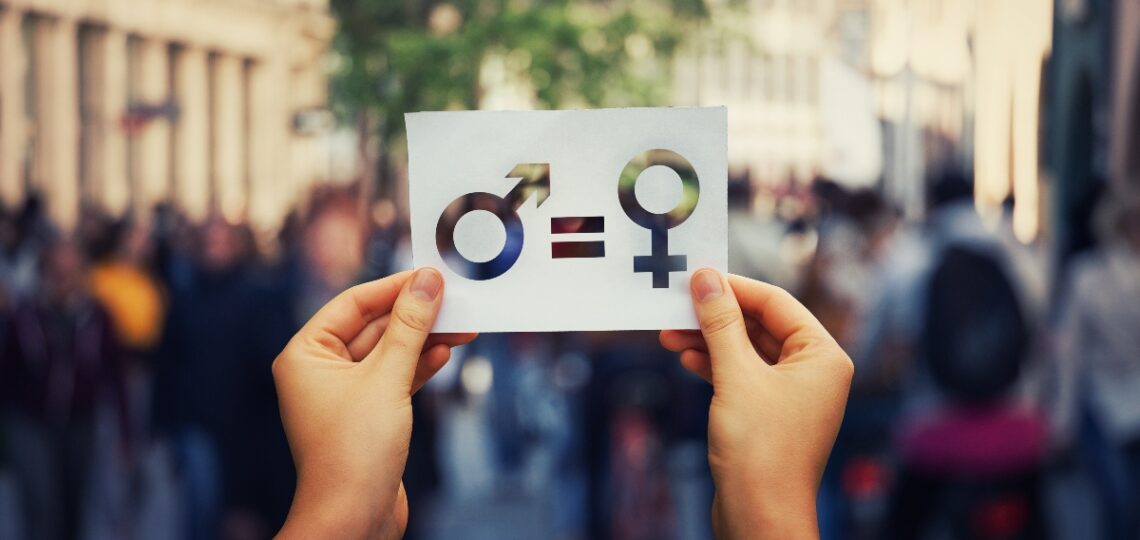
Giovani e genere
Cenni storici
Il concetto di genere è nato negli anni Settanta, quando le donne prendono coscienza del perdurare di una situazione di grave asimmetria e di squilibrio tra i ruoli sessuali.
 Da questa profonda consapevolezza sono poi nati studi, associazioni, movimenti e politiche atte a riequilibrare l’uguaglianza tra i due sessi.
Da questa profonda consapevolezza sono poi nati studi, associazioni, movimenti e politiche atte a riequilibrare l’uguaglianza tra i due sessi.
La distinzione concettuale di genere è stata proposta per la prima volta dalla sociologa inglese Anne Oakley nel suo libro “Sesso, genere e società” pubblicato nel 1972, e fa riferimento ai comportamenti sociali determinati dalla differenziazione sessuale maschio/femmina.
Il genere si costruisce culturalmente e riguarda i ruoli tipici e gli stereotipi che fanno parte dell’essere maschio e femmina in una certa classe sociale, in un certo periodo storico, ecc. Costruire e prendere consapevolezza del proprio genere è un processo lungo che parte dai 2 anni di vita e si completa con l’adolescenza.
Il genere indica i tratti sociali e culturali che qualificano il comportamento, il vissuto e i ruoli di una persona in termini di mascolinità o femminilità a differenza del sesso che fa riferimento alle caratteristiche biologiche e anatomiche degli individui.
Il termine genere è dunque usato in opposizione al termine sesso per indicare un processo di costruzione sociale contrapposto a un mero dato biologico. Il genere è il significato sociale assunto dalle differenze sessuali, designando l’insieme delle caratteristiche e dei comportamenti che ci si aspetta siano legati rispettivamente ai maschi e alle femmine.
In una società come quella attuale articolata e complessa, pluralista, multietnica e sempre più diversificata al suo interno, appare inevitabile porre attenzione alle differenze e pensare ai valori della convivenza in una dimensione molto più vasta rispetto al passato in una visione di impegno concreto contro le discriminazioni e le prevaricazioni.
Giovani e uguaglianza di genere nel mondo digitale
 Nell’Unione europea i giovani di entrambi i sessi si trovano al medesimo livello di competenze digitali e accesso a Internet, ma il loro comportamento online è differente. Nove giovani su dieci (il 92 % delle ragazze e il 93 % dei ragazzi) usano Internet ogni giorno. Nell’ambito dell’UE questa generazione, composta dalle persone di età compresa tra i 15 e i 24 anni, può vantare le competenze digitali più elevate: il 56 % delle ragazze e il 58 % dei ragazzi possiede in questo campo competenze superiori alla media.
Nell’Unione europea i giovani di entrambi i sessi si trovano al medesimo livello di competenze digitali e accesso a Internet, ma il loro comportamento online è differente. Nove giovani su dieci (il 92 % delle ragazze e il 93 % dei ragazzi) usano Internet ogni giorno. Nell’ambito dell’UE questa generazione, composta dalle persone di età compresa tra i 15 e i 24 anni, può vantare le competenze digitali più elevate: il 56 % delle ragazze e il 58 % dei ragazzi possiede in questo campo competenze superiori alla media.
Musica, posta elettronica e social network sono attività online ugualmente popolari tra ragazzi e ragazze, ma in altri settori emergono forti differenze
Gli spazi digitali sono luoghi in cui i giovani amano socializzare; sia i ragazzi che le ragazze usano attivamente i social media, ma in maniera differente. Un numero maggiore di ragazzi (26 %) che di ragazze (18 %) pubblica commenti su articoli online o tramite social network o blog. È anche più probabile che i ragazzi seguano dibattiti sui social media (55 %, rispetto al 46 % delle ragazze). Inoltre, maschi e femmine pubblicano online contenuti differenti. Le ragazze caricano una quantità maggiore di contenuti di loro creazione, come fotografie (60 %, rispetto al 56 % dei ragazzi). Secondo una tendenza analoga, il numero delle ragazze che pubblicano online opinioni su problemi sociali e politici, o partecipano a votazioni online, è minore di quello dei coetanei maschi. Le ragazze tendono più facilmente all’autocensura, poiché tengono conto delle possibili conseguenze negative della loro partecipazione online in ambito politico.
Dalle ragazze ci si aspetta che soddisfino standard tradizionali di bellezza, coltivino relazioni romantiche e un’intensa vita sociale; tuttavia, se passano il limite e si espongono in misura eccessiva sono giudicate negativamente. Di conseguenza censurano i propri profili online, poiché devono destreggiarsi tra i vantaggi sociali dell’autoesposizione e il rischio di essere giudicate con severità. I ragazzi sono costantemente esposti a media che rappresentano donne come oggetti e tollerano l’aggressività. Come evidenziato dai gruppi di discussione dell’EIGE, i ragazzi che non si uniformano all’ideale maschile raffigurato online subiscono pressioni e rischiano di essere derisi dagli amici.
L’uguaglianza di genere dovrà fare sempre parte delle future politiche e strategie dell’UE per la gioventù. Per ampliare le opportunità offerte dalla digitalizzazione e diminuirne i rischi, è necessario integrare una prospettiva di genere nelle politiche digitali dell’UE, come l’Agenda digitale europea, il programma «Safer Internet» (Internet più sicura) e il piano d’azione per l’istruzione digitale. Per rendere Internet più sicura, per le ragazze come per i ragazzi, è importante inoltre raccogliere dati ed elementi di prova sulla cui base progettare le misure politiche e valutarne l’efficacia.
Gli spazi digitali esaltano le tradizionali norme di comportamento legate alla femminilità e alla mascolinità, e ciò comporta conseguenze sulla partecipazione online dei giovani. Per affrontare questo problema, occorre svolgere opera di sensibilizzazione in merito agli stereotipi diffusi sia online che offline, attraverso percorsi didattici e promuovendo un uso sicuro e rispettoso di Internet. Stimolare la fiducia delle donne è un altro elemento chiave per sostenere la loro piena partecipazione online. Tramite l’apprendimento online, l’esposizione a idee politiche, i dibattiti e l’attivismo, è possibile incoraggiare le donne a diventare cittadine attive.
Giovani e disuguaglianze di genere nell’istruzione
Gli stereotipi di genere condizionano, sin dalla scolarizzazione di base, atteggiamenti, preferenze e impegno nei confronti delle diverse materie scolastiche: quelle scientifiche e tecnologiche vengono etichettate come più confacenti ai maschi, mentre quelle umanistiche sono considerate più da “femmine”.
Numerosi studi dimostrano che tali stereotipi influenzano le scelte formative e gli esiti scolastici di ragazzi e ragazze e sono responsabili di meccanismi di segregazione formativa e professionale che distinguono nettamente tra percorsi di studio e mestieri adatti agli uomini e alle donne.
 La letteratura evidenzia inoltre come sia di primaria importanza attuare programmi sociali ed educativi di contrasto alle disuguaglianze di genere nelle opportunità formative e di successo scolastico, sia per i maschi, sia per le femmine, come dimostrato dai dati sull’abbandono scolastico e sui giovani Neet.
La letteratura evidenzia inoltre come sia di primaria importanza attuare programmi sociali ed educativi di contrasto alle disuguaglianze di genere nelle opportunità formative e di successo scolastico, sia per i maschi, sia per le femmine, come dimostrato dai dati sull’abbandono scolastico e sui giovani Neet.
La maggioranza degli adolescenti non ama la scuola. Solo il 13% dei ragazzi, con proporzioni leggermente maggiori per le ragazze e per i più piccoli, dichiara di apprezzare la scuola. Percentuale che scende drammaticamente al 6% tra i 15enni. All’incirca il 75% dei ragazzi si sente accettato dai propri insegnanti ma solo la metà si fida molto di loro (55%) e percepisce da parte dei professori un vero interesse nei propri confronti (49%), con un trend in riduzione al crescere delle età. Di contro, circa la metà degli 11enni si sente molto stressato dagli impegni scolastici per crescere al 60% e al 78% rispettivamente nei ragazzi e nelle ragazze di 15 anni. In merito ai rapporti con i pari, il 60% dei giovani dichiara di avere amici disponibili e circa il 70% di sentirsi accettato per come è.
Il divario di genere nell’istruzione si è progressivamente ridotto nell’arco dei decenni. Fino a cambiare segno: oggi le donne tendono ad essere più scolarizzate degli uomini. È infatti meno probabile che abbandonino precocemente gli studi e che ripetano l’anno scolastico. Inoltre raggiungono più spesso della media un’istruzione di livello terziario, universitario o superiore.
Nonostante ciò, i dati sul mercato del lavoro continuano a mostrare che le maggiori competenze acquisite spesso non si traducono in maggiori tassi di occupazione né in redditi più alti.
L’educazione è uno strumento fondamentale per promuovere la parità di genere.
Nonostante i tentativi di incoraggiare la diversità di genere nella scelta del percorso di studi e delle carriere, la strada verso la parità è ancora lunga. I rapporti statistici indicano come sia ancora bassa la percentuale di donne sul totale dei laureati nelle tecnologie dell’informazione e in ingegneria. Una tendenza che esiste in tutti i paesi Ocse, e vale in particolare per l’Italia. Ciò genera disparità nei percorsi di carriera successivi: si tratta infatti di discipline che nel mercato del lavoro attuale sono maggiormente richieste ed offrono maggiore stabilità lavorativa e redditi medi più alti.
È stato indagato come queste disparità possano avere origine, oltre che nelle scelte personali, anche in stereotipi di genere, che possono finire con l’incoraggiare o meno certi percorsi di studio.
Le ricerche di Unicef sembrerebbero confermare questo aspetto, indicando come l’infanzia sia un’età più egualitaria di quanto ritenuto in passato. Le differenze di genere nell’istruzione, come in altri campi, spesso emergono durante l’adolescenza. Ad esempio con l’aumento del gap maschi-femmine sull’acquisizione delle competenze, con le ragazze che consolidano il vantaggio su quelle alfabetiche a discapito di quelle numeriche.
Processi che innescano un divario nei percorsi di studio e lavorativi successivi, sommandosi alle disparità già esistenti. La conseguenza è che attualmente una bambina ha meno probabilità di un coetaneo maschio essere occupata da adulta e avrà più probabilmente una retribuzione media più bassa.
La quota di donne diplomate o laureate è in aumento costante, e ha superato la rispettiva percentuale per gli uomini. Ma questa crescita ha avuto un andamento molto differenziato tra le diverse aree del paese.
Giovani e famiglia
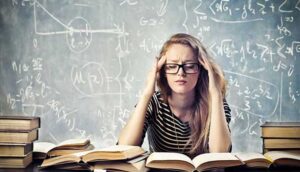 La pandemia ha migliorato i rapporti famigliari e il rendimento scolastico, ma ha aggravato la salute mentale e peggiorato, in generale, le condizioni di vita.
La pandemia ha migliorato i rapporti famigliari e il rendimento scolastico, ma ha aggravato la salute mentale e peggiorato, in generale, le condizioni di vita.
I giovani, in generale, hanno una discreta percezione della loro qualità di vita, anche se inferiore rispetto agli anni passati e maggiore tra i ragazzi rispetto alle ragazze. Nel complesso, gli adolescenti italiani si sentono supportati da amici e compagni di classe, si fidano degli insegnanti ma sono spesso stressati dagli impegni scolastici. Un adolescente su due ha dichiarato un impatto positivo della pandemia sui propri rapporti familiari e due su cinque sul rendimento scolastico. Pur dichiarando, sempre due adolescenti su cinque, che la propria salute mentale e la propria vita in generale ne abbiano risentito negativamente.
Il contesto familiare
I dati evidenziano che i nuclei familiari maggiormente presenti sono le famiglie di tipo tradizionale, che rappresentano l’82% e l’81% delle famiglie rispettivamente nelle regioni del Nord e del Sud, mentre sono leggermente inferiori nelle regioni del Centro (79%). Per quanto riguarda la comunicazione all’interno della famiglia, i dati HBSC confermano che al crescere dell’età diminuisce la facilità con cui i ragazzi si aprono ad entrambi i genitori. Le ragazze 13enni e 15enni, rispetto ai ragazzi coetanei, hanno una maggiore difficoltà a parlare con la figura paterna. In generale la madre rappresenta la figura di riferimento con cui i ragazzi e le ragazze comunicano maggiormente.
Si fanno più difficili i rapporti in famiglia. Il 68% dei ragazzi e il 60% delle ragazze percepisce una famiglia capace di sostenerli ed aiutarli nel prendere decisioni, di dare loro un supporto emotivo quando ne hanno bisogno, e di prestare ascolto ai loro problemi. Negli adolescenti 15enni però questa percentuale scende al 52% nelle ragazze ed al 61% nei ragazzi, evidenziando un trend negativo rispetto alla rilevazione del 2017/18 (67% nelle ragazze e 70% nei ragazzi).
I rapporti familiari, amichevoli e di genere
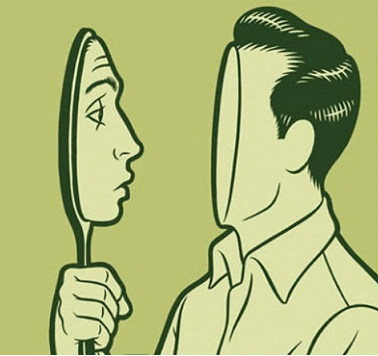 Nel percorso della formazione ogni individuo aspira ad ottenere un’immagine di sé che lo soddisfi e allo stesso tempo che si consideri di più gruppi sociale. Ciò comporta che deve faticare non poco per raggiungere quell’obiettivo. Altro elemento che ha una funzione fondamentale nella costruzione dell’identità è l’ambiente, nel quale l’individuo si adatta o al contrario vive il disagio dell’interazione con gli altri.
Nel percorso della formazione ogni individuo aspira ad ottenere un’immagine di sé che lo soddisfi e allo stesso tempo che si consideri di più gruppi sociale. Ciò comporta che deve faticare non poco per raggiungere quell’obiettivo. Altro elemento che ha una funzione fondamentale nella costruzione dell’identità è l’ambiente, nel quale l’individuo si adatta o al contrario vive il disagio dell’interazione con gli altri.
Nei percorsi di costruzione dell’identità oggi non si non può tenere conto di quello che viene definito policentrismo formativo, che consiste nell’allargamento nei contesti di formazione, dei tempi e delle agenzie di socializzazione, dunque la profonda trasformazione dei percorsi di socializzazione-apprendimento e l’inserimento dei mezzi elettrico-elettronici. Questi negli ultimi anni stanno svolgendo un’azione preponderante nella formazione delle nuove generazioni. Le seconde generazioni poi, in quanto adolescenti, sperimentano, per loro natura, forme diverse di interazione sociale, quando al contrario nei paesi di provenienza, ancora bambini, avevano stabilito relazioni in un contesto e dentro agenzie di socializzazione ben determinata, nelle quali erano riusciti a relazionarsi con il proprio corpo e con le proprie inclinazioni e capacità, oltre che con quei valori dominanti. Ovviamente durante l’adolescenza alcuni di questi legami hanno avuto un’evoluzione, per indirizzarsi verso l’età adulta, alla ricerca di una costruzione dell’identità, periodo in cui è fondamentale il senso di appartenenza. Ecco dunque che un adolescente migrante si trova nella condizione di rimettere in discussione i propri sensi di appartenenza e cercarne di nuovo, spesso trovati nei gruppi dei pari.
